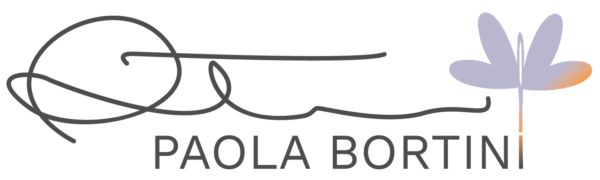Torna a: Mindful Self-Compassion

Cosa ci impedisce di essere più gentili con noi stessi?
Di Kristin Neff
La maggior parte delle persone non ha alcun problema nel considerare la compassione come una qualità assolutamente lodevole. Solitamente il termine viene associato a un amalgama di qualità indiscutibilmente buone: gentilezza, pietà, tenerezza, generosità, comprensione, empatia, simpatia e supporto reciproco, oltre all’impulso di volere aiutare altri esseri viventi, umani e animali, che sono in difficoltà. Ma queste certezze vengono meno quando si parla di self-compassion. Per molti è un termine che viene ricondotto a tutti gli altri contenenti la parola “self” (auto) in senso negativo: self-pity (auto- commiserazione), self-serving (egoismo), self-indulgent (indulgenza verso sé stessi), self-centered (egocentrismo), o semplicemente selfish (egoista). Nonostante molte generazioni si siano allontanate dalle origini puritane della nostra cultura, pare si continui a credere che, se non ci biasimiamo e non ci puniamo per qualcosa, rischiamo il compiacimento morale, l’egocentrismo fuori controllo e il peccato di falso orgoglio.
Prendete ad esempio Rachele, una dirigente di marketing di 39 anni con due figli e un marito amorevole. Una persona profondamente gentile, una moglie devota, una madre presente, un’amica premurosa e una grande lavoratrice, lei trova anche il tempo di fare volontariato per due enti di beneficienza locali. In pratica, sembra essere un perfetto modello da seguire. Rachel, però, è in terapia perché i suoi livelli di stress sono elevatissimi: è sempre stanca, depressa e non riesce a dormire. Soffre di problemi digestivi cronici di basso livello e a volte, con grande orrore da parte sua, si scaglia contro il marito e i figli. In tutto questo, lei è incredibilmente dura con sé stessa, sente sempre che tutto ciò che fa non è abbastanza. Eppure, non ha mai preso in considerazione di provare ad essere compassionevole con sé stessa. Anzi, l’idea stessa di lasciare andare l’autocritica, regalandosi un po’ di gentilezza e comprensione, le sembra in qualche modo un comportamento infantile e irresponsabile.
E Rachele non è la sola. Molte persone nella nostra cultura hanno dubbi circa l’idea della compassione verso di sé, forse perché non sanno realmente di cosa si tratta, tantomeno come praticarla. Spesso la pratica della self-compassion è associata alla mindfulness, ormai diffusa come il sushi in Occidente. Ma se la mindfulness, che mette enfasi sull’essere esperienzialmente aperti e consapevoli della nostra sofferenza senza farci travolgere da una reazione negativa, è necessaria per la compassione verso sé stessi, al tempo stesso lascia fuori un elemento essenziale. Ciò che contraddistingue la self-compassion è il suo andare oltre l’accettazione della nostra esperienza così com’è, aggiungendo un elemento in più, ovvero abbracciando chi fa l’esperienza (per esempio noi stessi) con calore e tenerezza quando la situazione che stiamo vivendo è dolorosa.
La self-compassion comprende anche un elemento di saggezza, il riconoscimento della nostra comune umanità. Questo significa accettare il fatto che, come tutti su questo pianeta, siamo individui imperfetti con tanti difetti, proprio come qualsiasi persona che può essere colpita da una sfortuna oltraggiosa, ma il che è perfettamente normale. Può sembrare un concetto ovvio, ma è curioso vedere quanto facilmente ce ne dimentichiamo. Cadiamo nella trappola di credere che le cose “dovrebbero” sempre andare bene e che quando facciamo un errore o si presenta una difficoltà, qualcosa deve essere andato terribilmente storto. (Oh, mi scusi. Ci deve essere un errore. Mi sono iscritta al piano “tutto andrà bene fino al giorno della mia morte”. Posso parlare con un responsabile per cortesia?). La sensazione che certe cose “non dovrebbero” accadere ci fa provare vergogna e ci fa sentire isolati. In quei momenti, ricordare che non siamo veramente soli nella nostra sofferenza, che le difficoltà e le sofferenze sono profondamente radicate nella condizione umana, può fare la differenza.
Ricordo che un giorno ero al parco con mio figlio Rowan, all’epoca aveva circa 4 anni, nel suo momento di massimo autismo. Ero seduta sulla panchina, a guardare tutti i bambini felici che giocavano sul dondolo, che correvano e si divertivano, Rowan invece era seduto in cima allo scivolo mentre sbatteva ripetutamente la mano accanto a sé (cosa nota con il nome di stimming). Ammetto di aver preso inizialmente la strada dell’auto-commiserazione: “Perché non posso avere un figlio “normale” come tutti gli altri? Perché sono l’unica che sta passando un momento così difficile?”. Ma anni di pratica della self-compassion mi hanno dato abbastanza lucidità per riprendermi, fare una pausa, fare un bel respiro, e prendere consapevolezza della trappola in cui stavo per cadere.
Prendendo le distanze dai miei pensieri e sentimenti negativi, ho guardato le altre madri e i loro figli e ho pensato tra me e me: “Presumo che questi bambini cresceranno con spensieratezza, senza problemi, e che nessuna di queste madri dovrà lottare nell’educare i propri figli. Ma per quanto ne so, alcuni di questi bambini potrebbero sviluppare seri problemi di salute fisica o mentale, o semplicemente rivelarsi persone non del tutto buone! Nessun bambino è perfetto e non c’è genitore che non abbia dovuto fronteggiare un momento difficile con i propri figli”. E in quel momento, i miei sentimenti di intensa solitudine si sono trasformati in sentimenti di profonda connessione con le altre madri del parco, e con tutti i genitori del mondo. Amiamo i nostri bambini, ma dannazione, a volte è davvero dura! Per quanto possa sembrare strano, praticando la self-compassion mentre cerchiamo di fare del nostro meglio, ci fa sentire meno soli.
Fortunatamente, non si tratta solo di una pia illusione o un altro approccio di self-help (auto-aiuto). Infatti, ad oggi c’è un numero sempre più impressionante e crescente di ricerche che dimostrano che relazionarsi con noi stessi in modo gentile e amichevole è essenziale per il nostro benessere emotivo. Non solo ci aiuta ad eludere le inevitabili conseguenze di un duro auto-giudizio, depressione, ansia e stress, ma genera anche un approccio alla vita più felice e pieno di speranza. Più precisamente, la ricerca sfata molti dei miti comuni sulla self-compassion che ci tengono intrappolati nella gabbia della spietata auto-critica.
Mito 1
La self-compassion è una forma di auto-commiserazione
Uno dei più grandi miti sulla self-compassion è quello di intenderla con il significato di dispiacersi per sé stessi. In realtà, come dimostra la mia esperienza al parco giochi, la self-compassion è un antidoto all’auto-commiserazione e alla tendenza a lamentarci della nostra sfortuna. Questo non è perché la compassione di sé permette di ignorare le cose brutte; anzi, ci rende più disposti ad accettare, a sperimentare e riconoscere sentimenti complessi con gentilezza, aiutandoci paradossalmente a elaborarli e a lasciarli andare completamente. Le ricerche dimostrano che le persone auto-compassionevoli hanno meno probabilità di lasciarsi inghiottire da pensieri di commiserazione su quanto siano brutte le cose. Questa è una delle ragioni per la quale le persone auto-compassionevoli hanno una salute mentale migliore.
Uno studio condotto da Filip Raes dell’Università di Leuven ha preso in esame l’associazione di self-compassion con il pensiero meditativo e la salute mentale tra i laureandi alla sua università. Per prima cosa ha valutato come i partecipanti stavano usando il report con la Scala di Self-Compassion che ho sviluppato nel 2003, che chiede agli intervistati di indicare con quale frequenza si impegnano in comportamenti che corrispondono ai principali elementi della self-compassion. Alcuni esempi sono affermazioni come “Cerco di essere comprensiva e paziente verso gli aspetti della mia personalità che non mi piacciono”, “Quando le cose mi vanno male, vedo le difficoltà come qualcosa che fa parte della vita e attraverso cui tutti passano”, “Quando succede qualcosa di doloroso, cerco di vedere le cose da una prospettiva obiettiva della situazione”. Raes ha scoperto che i partecipanti con un livello più alto di self-compassion tendevano a rimuginare meno sulla loro sfortuna. Inoltre, ha avuto modo di notare come il fatto di rimuginare meno aiutasse a spiegare perché i partecipanti auto-compassionevoli riportassero meno sintomi di ansia e depressione.
Mito 2
Self-compassion significa debolezza
John si è sempre considerato un uomo forte, un marito e un partner ideale. Pertanto è rimasto devastato quando sua moglie lo ha lasciato per un altro uomo. Segretamente tormentato dal senso di colpa per non aver fatto di più per soddisfare i suoi bisogni emotivi, prima che lei cercasse conforto nelle braccia di qualcun altro, non riusciva ad ammettere quanto si sentisse ancora ferito e quanto fosse difficile per lui andare avanti con la sua vita. Quando il suo collega gli ha suggerito di provare a essere compassionevole con sé stesso per il divorzio, la sua reazione è stata immediata: “Non parlarmi di quella tiritera sentimentale, di cuori e fiori! La self-compassion è per femminucce. Ho dovuto essere duro come il marmo per affrontare il divorzio con una parvenza di dignità, e non ho intenzione di abbassare la guardia proprio adesso”.
Ciò che John non sapeva è che non si tratta di un punto debole, al contrario i ricercatori stanno scoprendo che la self- compassion è una delle fonti più potenti di resilienza a nostra disposizione per affrontare le difficoltà. Quando attraversiamo grandi crisi esistenziali, la self-compassion sembra fare la differenza per la nostra capacità di sopravvivere e addirittura crescere. John pensava che comportarsi da duro durante il divorzio, soffocando i suoi sentimenti e non ammettendo quanto abbia sofferto, sia ciò che gli ha permesso di superarlo. Ma lui non lo ha “superato”: è rimasto bloccato, e la self-compassion era il pezzo mancante che probabilmente lo avrebbe aiutato ad andare avanti.
David Sbarra e i suoi colleghi dell’Università dell’Arizona hanno esaminato la possibilità che la self-compassion possa essere d’aiuto nel determinare quanto bene le persone si adattino al divorzio. I ricercatori hanno invitato nel laboratorio più di 100 persone recentemente separate dai propri coniugi per fare un flusso di coscienza della durata di quattro minuti, registrando i loro pensieri e sentimenti riguardo la loro esperienza di separazione. Quattro giudici qualificati, hanno poi codificato il livello di self-compassion di queste discussioni usando una versione modificata della Scala di Self-Compassion. Hanno assegnato un punteggio basso ai partecipanti che hanno detto cose come “Non so come sono riuscito a farlo. È stata tutta colpa mia. L’ho allontanato per qualche motivo. Avevo tanto bisogno di lui, ho ancora bisogno di lui. Cosa ho fatto? So di aver sbagliato tutto”. I punteggi più alti, invece, sono stati dati a persone che hanno detto cose come “Guardando indietro, bisogna tirare fuori il meglio e andare avanti. Bisogna perdonare sé stessi e il proprio ex per tutto ciò che entrambi abbiamo o non abbiamo fatto”.
I ricercatori hanno constatato che i partecipanti che hanno mostrato più self-compassion parlando delle loro separazioni hanno evidenziato un migliore adattamento psicologico al divorzio in quel momento, e che questo effetto è persistito anche dopo nove mesi. Si sono ottenuti risultati anche quando si stavano cercando altre possibili spiegazioni, come il livello iniziale di autostima nei partecipanti, l’ottimismo, la depressione o l’attaccamento sicuro. Studi come questo dimostrano che non è solo ciò che si affronta nella vita, ma anche il modo in cui ci si relaziona con sé stessi quando il gioco si fa duro, come un alleato interno o un nemico, sia un elemento fondamentale per determinare la capacità di affrontare con successo qualcosa.
Mito 3
La self-compassion mi renderà compiacente
Forse il più grande ostacolo alla self-compassion è la convinzione che possa compromettere la nostra motivazione nello spingerci a fare meglio. L’idea è che se non critichiamo noi stessi per non essere stati all’altezza dei nostri standard, soccomberemo automaticamente ad un atteggiamento disfattista. Ma pensiamo un attimo a come i genitori motivano i loro figli con successo. Quando un giorno il figlio adolescente di Rachel torna a casa con un’insufficienza in inglese, lei potrebbe reagire con disgusto e urlare: “Stupido ragazzo! Non riuscirai mai a fare niente. Mi vergogno di te!”. (Ti fa venire i brividi, vero? Eppure è esattamente il tipo di cosa che Rachel si dice quando non riesce a soddisfare le sue aspettative più alte). Ma è più probabile che questo fiume di vergogna, invece di motivare il figlio, gli farà solo perdere la fiducia in sé stesso, e alla fine smetterà di provarci del tutto.
In alternativa, Rachel potrebbe adottare un approccio compassionevole dicendo: “Oh tesoro, sarai turbato. Ehi, dammi un abbraccio. Può succedere a tutti. Ma dobbiamo cercare di alzare i tuoi voti di inglese perché so che vuoi entrare in un buon college. Cosa posso fare per aiutarti e sostenerti? Io credo in te”. Notate che c’è un onesto riconoscimento del fallimento, la comprensione per l’infelicità del figlio e l’incoraggiamento ad andare oltre o aggirare questo ostacolo momentaneo. Questo tipo di risposta premurosa ci aiuta a mantenere la fiducia in noi stessi e a sentirci sostenuti emotivamente. Paradossalmente, anche se Rachel mai si sognerebbe di adottare il primo approccio con suo figlio, crede indiscutibilmente che l’auto-flagellazione sia necessaria per raggiungere i propri obiettivi. È convinta che la sua ansia, la depressione e lo stress siano il risultato del fatto che non si è sforzata abbastanza.
Ci sono, però, ad oggi numerose ricerche che dimostrano chiaramente che la self-compassion è un elemento di forza per la motivazione personale, molto più efficace dell’auto-punizione. Per esempio, una serie di esperimenti di ricerca condotti da Juliana Breines e Serena Chen dell’Università della California di Berkeley ha valutato se aiutare gli studenti ad essere più auto-compassionevole li avrebbe motivati ad impegnarsi maggiormente in un cambiamento positivo. In uno studio, è stato chiesto ai partecipanti di pensare ad un’azione recente per la quale si sentivano in colpa, come per esempio copiare ad un esame, mentire al proprio partner, dire qualcosa di brutto a qualcuno, e che ancora li faceva stare male quando ci pensavano. Successivamente, sono stati assegnati casualmente a una di tre diverse condizioni. Nella condizione della compassione di sé, è stato richiesto ai partecipanti per tre minuti di scrivere a sé stessi dal punto di vista di un amico compassionevole e comprensivo. Nella seconda condizione, è stato richiesto ai partecipanti di scrivere sulle proprie qualità positive; e nella terza, di scrivere di un hobby che gli è piaciuto tanto. Queste due condizioni di controllo sono servite a differenziare la self- compassion da un dialogo interiore positivo o un atteggiamento positivo in generale.
I ricercatori hanno potuto constatare che i partecipanti che sono stati portati ad essere auto-compassionevoli sulla loro recente trasgressione si sono mostrati più motivati a perdonarsi per il torto commesso e più intenzionati a non ripetere il comportamento rispetto ai partecipanti delle altre due condizioni. La self-compassion, non è certo un modo per eludere la responsabilità personale, anzi la rafforza. Se riusciamo a riconoscere i nostri fallimenti e i nostri errori con gentilezza (“Ho davvero fatto un gran casino quando mi sono arrabbiata con lei, ma ero stressato, e credo che a tutti possa capitare di reagire in modo eccessivo”), piuttosto che condannarci (“Non posso credere di averlo detto; sono una persona orribile e cattiva”), diventa molto più facile riuscire a vedere noi stessi con chiarezza. Quando riusciamo a vedere oltre la lente distorta del duro auto-giudizio, entriamo in contatto con altre parti di noi stessi, quelle che si preoccupano e vogliono che tutti, noi compresi, siano il più sani e felici possibile. Tutto ciò ci offre l’incoraggiamento e il sostegno di cui abbiamo bisogno per fare il nostro meglio e riprovarci.
Mito 4
La self-compassion è narcisistica
Nella cultura americana, l’alta autostima richiede di sapersi distinguere in una folla, di essere speciale e al di sopra della media. Come ti senti quando qualcuno giudica il tuo rendimento lavorativo, o le tue capacità genitoriali, o il tuo livello di intelligenza medio? Ahi! Il problema, naturalmente, è che è impossibile essere tutti al di sopra della media allo stesso tempo. Possiamo eccellere in alcune cose, ma c’è sempre qualcuno di più attraente, più bravo o intelligente di noi; il che significa che ci sentiamo dei falliti ogni volta che ci mettiamo a confronto con quelli “migliori” di noi.
Tuttavia, il desiderio di vederci superiori alla media per ottenere e mantenere quella fugace sensazione di alta autostima, può portare a comportamenti decisamente sgradevoli. Perché gli adolescenti più grandi iniziano a fare i bulli con gli altri? Se posso essere visto come il ragazzino figo e tosto in confronto con lo smidollato che ho appena preso di mira, avrò un aumento di autostima. Perché siamo così prevenuti? Se credo che la mia etnia, il mio genere, la mia nazionalità, o il mio schieramento politico sia migliore del tuo, avrò un aumento di autostima.
In effetti, l’enfasi posta sull’autostima nella società americana ha portato a una tendenza preoccupante: i ricercatori Jean Twenge dell’Università Statale di San Diego e Keith Cambell dell’Università della Greorgia, hanno tenuto traccia del livello di narcisismo degli studenti universitari dal 1987, e hanno scoperto che il narcisismo degli studenti di oggi è al più alto livello mai registrato. Loro attribuiscono l’incremento del livello di narcisismo a genitori e insegnanti con buone intenzioni, ma incauti, che continuano a dire ai propri bambini quanto sono speciali e fantastici nel tentativo di aumentare la loro autostima.
Ma la self-compassion è diversa dall’autostima. Sebbene entrambe siano strettamente legate al benessere psicologico, l’autostima è una valutazione positiva della considerazione di sé, mentre la self-compassion non è affatto un giudizio o una valutazione. Al contrario, la self-compassion è un modo di rapportarsi al nostro essere in continuo cambiamento con gentilezza e accettazione, soprattutto quando falliamo o ci sentiamo inadeguati. In altre parole, l’autostima richiede di sentirsi meglio rispetto agli altri, mentre la self-compassion richiede la consapevolezza che tutti condividiamo la condizione umana dell’imperfezione.
L’autostima è anche intrinsecamente fragile, va su e giù a seconda del nostro ultimo successo o fallimento. Ricordo un momento in cui la mia autostima è salita e poi è crollata in circa cinque secondi. Stavo visitando un maneggio con alcuni amici e al vecchio istruttore di equitazione spagnolo che era lì, a quanto pare, piaceva il mio aspetto mediterraneo. “Sei mooooolto bella”, mi disse, mentre io mi illuminavo di gioia. Poi aggiunse, “Non farti mai i baffetti”. L’autostima è una falsa amica, è lì per noi nei momenti buoni, ma poi ci abbandona quando la fortuna cambia strada. Invece la self-compassion è sempre lì, una fonte affidabile di sostegno, anche quando tutte le nostre certezze sono crollate. Continuiamo a stare male quando il nostro orgoglio è distrutto, ma possiamo essere gentili con noi stessi proprio perché stiamo già male. “Wow, è stato piuttosto umiliante, sono così dispiaciuta. Ma non fa niente, queste cose possono succedere”.
C’è un valido studio circa l’idea che la self-compassion ci più aiutare nella buona e nella cattiva sorte. Mary Leary insieme ai suoi colleghi della Wake Forest University hanno condotto uno studio che chiedeva ai partecipanti di realizzare un video in cui bisognava presentarsi e descriversi. Per esempio, “Ciao, sono John, laureato in scienze ambientali. Mi piace andare a pesca e passare il tempo in mezzo alla natura. Una volta laureato vorrei lavorare nel Servizio del Parco Nazionale”, e così via. È stato detto loro che qualcuno avrebbe visto il loro video e sarebbero stati valutati su una scala di sette punti massimo in base a come si presentava il loro atteggiamento: caldo, amichevole, intelligente, simpatico o maturo. (Il feedback ovviamente era fasullo, veniva dato da un assistente dello studio in questione). La metà dei partecipanti ha ricevuto valutazioni positive mentre gli altri, valutazioni neutrali. I ricercatori volevano esaminare se i livelli di self-compassion dei partecipanti (come misurato dai punteggi della Scala di Self-Compassion), avrebbe predetto le reazioni al feedback in modo diverso rispetto al loro livello di autostima (misurato con la Scala di Autovalutazione dell’Autostima di Rosenberg).
Hanno potuto constatare come le persone auto-compassionevoli hanno riportato reazioni emotive simili in termini di quanto felici, tristi, arrabbiati o tesi si sentissero, indipendentemente dal fatto che il feedback fosse positivo o neutrale. Le persone con alti livelli di autostima, tuttavia hanno avuto la tendenza ad arrabbiarsi in caso di feedback neutrale (“Cosa, sono nella media?”). Erano più propensi a negare che il feedback si bassasse sulla loro personalità e che la colpa era da attribuire a fattori esterni, come ad esempio che l’esaminatore era di cattivo umore. Questo suggerisce che le persone auto-compassionevoli sono in grado di rimanere più emotivamente stabili, indipendentemente dal tipo di valutazione che ricevono dagli altri. L’autostima, al contrario, prospera solo quando le valutazioni sono buone, e può portare a tattiche evasive quando c’è la possibilità di dover affrontare una verità spiacevole su sé stessi.
Mito 5
La self-compassion è egoismo
Molti mostrano un atteggiamento sospettoso nei riguardi della self-compassion perché la associano all’egoismo. Rachel, per esempio, passa gran parte delle sue giornate a prendersi cura della sua famiglia e buona parte delle notti e dei weekend a fare volontariato per gli enti di beneficienza da lei sostenuti. Cresciuta in una famiglia che ha sempre sottolineato l’importanza del servizio agli altri, presume che spendere tempo ed energie per essere gentile e amorevole verso se stessa significhi automaticamente trascurare tutti gli altri per i propri fini egoistici. In effetti, molte persone sono come Rachel in questo senso, anime buone, generose, altruiste che al tempo stesso sono assolutamente terribili con se stesse, mentre pensano che questo sia necessario per la loro bontà generale.
Ma la compassione è davvero un gioco a somma zero? Pensate ai momenti in cui vi siete persi in preda all’auto-critica. In quei momenti siete concentrati su voi stessi o su altri aspetti? Avete più o meno risorse da dare agli altri? La maggior parte delle persone trovano che quando sono in presa all’auto-critica, in realtà hanno poca energia a disposizione per pensare a qualcosa di diverso dal loro essere inadeguati e inutili. Infatti, tormentarsi può essere una forma paradossale di egocentrismo. Quando possiamo essere gentili e amorevoli con noi stessi, tuttavia, molti dei nostri bisogni emotivi sono soddisfatti, lasciandoci in una posizione migliore per concentrarci sugli altri.
Purtroppo, l’ideale di essere modesti, umili e di prendersi cura del benessere degli altri spesso viene associato al fatto che dobbiamo trattarci male. Questo vale soprattutto per le donne che, secondo varie ricerche, tendono ad avere livelli di self-compassion leggermente inferiori a quelli degli uomini, nonostante abbiano la tendenza ad essere più premurose, empatiche e generose nei confronti degli altri. Probabilmente non è così sorprendente dato che le donne sono educate dalla società a prendersi cura degli altri (caregivers) in maniera disinteressata per aprire i loro cuori ai mariti, ai figli, agli amici e ai genitori anziani, ma non gli viene insegnato a prendersi cura di sé stesse. Se da una parte la rivoluzione femminista ha contribuito ad ampliare i ruoli disponibili per le donne, e ora vediamo sempre più donne in posizioni di leadership nel mondo degli affari e della politica, tuttavia l’idea che le donne debbano essere delle caregiver disinteressate è ancora presente. È solo che ora si presuppone che le donne debbano avere successo nella loro carriera lavorativa, oltre ad essere perfette educatrici a casa.
La cosa ironica è che essere buoni con sé stessi aiuta a essere buoni con gli altri, mentre essere cattivi con sé stessi rappresenta solo un ulteriore ostacolo. Infatti, di recente ho condotto uno studio con la mia collega Tasha Beretvas dell’Università del Texas di Austin, in cui abbiamo esaminato se le persone auto-compassionevoli fossero i partner più generosi in una relazione. Abbiamo reclutato più di 100 coppie con una relazione sentimentale di almeno un anno. I partecipanti hanno valutato il proprio livello di self-compassion attraverso la Scala di Self-Compassion. Hanno poi descritto il comportamento del partner nella relazione su una serie di misure soggettive (auto-valutazione), indicando anche quanto erano soddisfatti del loro partner. Abbiamo constatato che gli individui auto-compassionevoli sono stati descritti dai loro partner come più premurosi (per esempio “gentile e dolce verso di me”), aperti e tolleranti (per esempio “rispetta le mie opinioni”), e in grado di sostenere l’autonomia dell’altro (ad esempio “mi dà tutte le libertà di cui ho bisogno”) rispetto alle loro controparti auto-critiche, i quali sono stati descritti come più distaccati (per esempio “non pensa molto a me”), aggressivi (per esempio “urla, ed esce in modo brusco dalla stanza”) e dispotici (ad esempio “pretende che io faccia tutto a modo suo”).
I partecipanti hanno anche riferito di essere più soddisfatti e sicuri nelle relazioni con partner auto-compassionevoli, il che ha senso. Se ci si trattiene e ci si affida al partner per soddisfare le proprie esigenze emotive, inevitabilmente nel momento in cui non dovessero essere soddisfatte si reagirà in modo negativo. Ma se riesco a prendermi cura di me stesso, sostenendomi e soddisfacendo molti dei miei bisogni in modo diretto, avrò a disposizione più risorse emotive da dare al mio partner.
In letteratura non è chiaro se la self-compassion sia effettivamente necessaria per essere compassionevoli con gli altri, dato che molti fanno un buon lavoro nel prendersi cura degli altri, ma sottovalutando sé stessi. Tuttavia, un numero crescente di ricerche indica che la self-compassion aiuta le persone a sostenere l’atto di prendersi cura degli altri. Per esempio, sembra che i consulenti e i terapisti che sono auto-compassionevoli hanno meno probabilità di sperimentare stress ed esaurimento da caregiver, sono più soddisfatti della propria carriera e si sentono più energici, felici e grati di poter fare la differenza nel mondo. Poiché ci siamo evoluti come esseri sociali, l’esposizione ai racconti di sofferenza degli altri attiva i centri del dolore del nostro cervello attraverso un processo di risonanza empatica. Quando assistiamo quotidianamente alla sofferenza degli altri, possiamo provare un sentimento di angoscia talmente grande da farci scoppiare, e i caregiver che sono particolarmente sensibili ed empatici, possono essere più a rischio. Allo stesso tempo quando proviamo compassione, creiamo una sorta di cuscinetto protettivo che ci permette di comprendere e sentire il dolore di una persona senza essere prosciugati dalla sua sofferenza. Le persone che amiamo raccolgono la nostra compassione attraverso il loro processo di risonanza empatica. In altre parole, la compassione che coltiviamo per noi stessi si trasmette agli altri in modo diretto.
È qualcosa che ho vissuto in prima persona attraverso la mia esperienza nell’educare un bambino autistico. Rowan ora ha 13 anni, e anche se a volte può mostrarsi scontroso, è un bambino affettuoso, che pone poche sfide genitoriali. Ma non è sempre stato così. Spesso ho affrontato situazioni che pensavo fossero al di là delle mie capacità, e a volte ho dovuto fare affidamento sul potere della self-compassion per superarle. Una volta, quando Rowan aveva 5 anni, l’ho portato in Inghilterra a trovare i nonni. Nel bel mezzo del volo intercontinentale, ha iniziato a fare i capricci. Non ho idea di cosa l’abbia fatto scattare, ma mi sono ritrovata improvvisamente con un bambino che si agitava e urlava e allo stesso tempo un aereo intero che ci fissava con sguardo truce. Che fare a quel punto? Ho provato a portarlo in bagno nella speranza che la porta chiusa potesse attutire le sue urla. Ma dopo averlo trascinato lungo il corridoio, cercando di evitare che colpisse accidentalmente i passeggeri, ho scoperto che il bagno era occupato.
Rannicchiata con Rowan nel minuscolo spazio fuori dal bagno, mi sentivo impotente e senza speranza. Poi, però, mi sono ricordata della self-compassion. È così difficile per te, tesoro, mi sono detta. Mi dispiace per quanto sta accadendo. Sono qui per te. Mentre mi assicuravo che Rowan fosse al sicuro, il 90% della mia attenzione si era focalizzata su come calmarmi e confortarmi. La mia mente si è inondata di compassione, al punto da prevalere sulla situazione che stavo vivendo, anche su mio figlio che urlava. Inoltre, come avevo già potuto constatare, quando riuscivo ad entrare in una dimensione psicologica più tranquilla e amorevole, anche Rowan riusciva a calmarsi.
Conclusioni
Quando ci prendiamo cura di noi stessi con gentilezza per reagire alla sofferenza, il nostro cuore si apre. La compassione coinvolge la nostra capacità di amore, saggezza, coraggio e generosità. È uno stato emotivo e mentale senza limiti, fondato sulle grandi tradizioni spirituali del mondo, ma a disposizione di ognuno di noi semplicemente in virtù del nostro essere umani. In un sorprendente colpo di scena, il potere benefico della self-compassion è ora illuminato da un dato di fatto, rigorosi metodi della scienza empirica e un numero crescente di ricerche stanno dimostrando in modo conclusivo che la self- compassion non è solo fondamentale per la salute mentale, ma può essere arricchita attraverso l’apprendimento e la pratica, proprio come tante altre buone abitudini. I terapeuti sanno da tempo che essere gentili con sé stessi non è, come troppo spesso si crede, un lusso egoistico, ma l’esercizio di un dono che ci rende più felici. Ora la scienza lo sta finalmente dimostrando.
—
Kristin Neff, PhD, è professoressa associata di psicologia educativa presso l’Università del Texas di Austin. È autrice di Self-Compassion: Il potere dell’essere gentili con se stessi e del set di 6 CD audio La self-compassion passo dopo passo. Insieme a Chris Germer, ha sviluppato un programma di formazione supportato empiricamente e offre workshop sulla self- compassion.
Questo articolo è stato originariamente pubblicato su Psycotherapy Networker.
Traduzione a cura di Paola Musto
References
- Breines, J. G., & Chen, S. (2012). Self-compassion increases self-improvement motivation. Personality and Social Psychology Bulletin, 38(9), 1133–1143.
- Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Allen, A. B., & Hancock, J. (2007). Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: The implications of treating oneself kindly. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 887–904.
- Neff, K. D. (2003). Development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2, 223–250.
- Neff, K. D., & Beretvas, S. N. (2013). The role of self-compassion in romantic relationships. Self and Identity, 12(1), 78– 98.
- Raab, K. (2014). Mindfulness, self-compassion, and empathy among health care professionals: a review of the literature. Journal of Health Care Chaplaincy, 20(3), 95–108.
- Raes, F. (2010). Rumination and worry as mediators of the relationship between self- compassion and depression and anxiety. Personality and Individual Differences, 48, 757– 761.
- Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Sbarra, D. A., Smith, H. L., & Mehl, M. R. (2012). When leaving your ex, love yourself: Observational ratings of self-compassion predict the course of emotional recovery following marital separation. Psychological Science, 23(3), 261–269.
- Twenge, J. M., & Campbell, W. K. (2009). The narcissism epidemic: Living in the age of entitlement.
- Simon and Schuster, Yarnell, L. M., Stafford, R. E., Neff, K. D., Reilly, E. D., Knox, M. C., & Mullarkey, M. (2015). Meta-analysis of gender differences in self-compassion. Self and Identity.